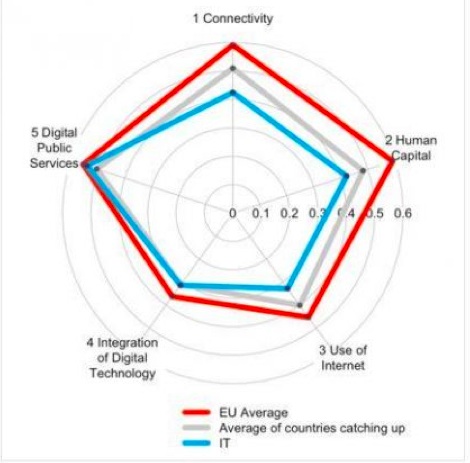L'Unione Europea, a seguito di un rapporto presentato a fine maggio, potrebbe mettere allo studio una legge per tamponare l’incremento dell’uso di robot; intesa a compensare la perdita di posti di lavoro di esseri umani. E, come risultato, a scoraggiare l’uso di robotica e intelligenza artificiale. Il rapporto dichiara che robotica e intelligenza artificiale possono danneggiare l’esistenza di una gran parte del lavoro ormai fatto da esseri umani, sollevando preoccupazioni per il futuro dell'occupazione e per la congruità dei sistemi di sicurezza sociale. La soluzione è dichiarare i robot “persone elettroniche”.
Il percorso legislativo è ancora all’inizio: un piccolo comitato del Parlamento Europeo ne sta discutendo da settimane; e il risultato di queste discussioni verrà poi presentato all’intero Parlamento. Questa discussione più ampia, in realtà, potrebbe durare un certo tempo; infatti, poiché i tentativi di legiferazione, in UE, sono innumerevoli, ad ognuno di essi i parlamentari sono soliti dedicare pochi nanosecondi di attenzione. Ma tant’è: il disegno di legge, anticipato con un rapporto il 31 maggio, verrà presentato; e vale la pena analizzarlo; per capirne le logiche e le contro-logiche.
Anche perché quello che tale legge in fieri vorrebbe significare è che, chiunque abbia l'ardire di utilizzare robot nella sua fabbrica, al posto di esseri umani, deve anche essere disposto a pagare imposte previdenziali più alte.
Il problema dei robot (se problema è) è che sono molto convenienti per il datore di lavoro. Innanzitutto i robot non vanno in pensione (e quindi, tra l’altro, non debbono risparmiare per pensioni integrative); non si ammalano come gli umani; e comunque la loro riparazione, se si guastano, la paga il proprietario, non lo Stato. Non si sposano (almeno per ora), non fanno figli, non hanno una famiglia, non vanno a scuola, eccetera. Ecco perché sono attraenti per un datore di lavoro; soprattutto in un'epoca in cui l'automazione è sempre più economica mentre i lavoratori umani diventano sempre più costosi, indisciplinati e, quindi, socialmente ingombranti.
Ma è appurato che questo incremento di robotizzazione rappresenti una minaccia lampante per il quadro pensionistico generale.
Secondo il rapporto UE sui robot (*), la loro intelligenza crescente, la loro pervasività ed autonomia richiede un ripensamento di tutto, dalla tassazione alle responsabilità legali, e necessita pertanto di uno specifico progetto del Parlamento Europeo. Non siamo ancora alle “tre leggi della robotica” di Asimov, ma non ne siamo lontani; anzi: nel rapporto, queste tre leggi sono specificamente menzionate e considerate applicabili (sic !).
Soluzioni possibili?
Ovviamente se si desse uno stipendio ai robot, preferibilmente medio alto, il tutto verrebbe immediatamente risolto con una congrua tassazione standard alla fonte; ma questo toglierebbe la convenienza per il datore di lavoro. Anche se comunque si dovrebbe pensare che i robot possano essere meno assenteisti, meno pretenziosi (es. ticket-restaurant, auto aziendale) e non abbiano bisogno di sindacati.
Ma nel rapporto viene presentata un’altra brillante soluzione:
Nel rapporto, infatti, viene suggerito che ai robot in Europa vengano dati diritti legali, e gli stessi considerati "persone elettroniche". Di conseguenza, i datori di lavoro sarebbero tenuti a pagare i contributi sociali, per conto dei propri lavoratori robot, proprio come fanno per i lavoratori umani.
Nasce però un ovvio problema: se i robot sono “persone” e vengono tassati alla fonte, i soldi relativi alla pensione non vengono dati al robot quando lo si demolisce; e quindi i robot non otterrebbero le pensioni per cui hanno pagato. E questo potrebbe far nascere un problema costituzionale se i robot venissero considerati, come appunto proposto, persone: “persone elettroniche”. Non solo; in realtà il problema reale è:”ma se questi soldi non vanno a pagare la pensione del robot, a chi vanno ?”. La risposta più logica, in Italia, sarebbe : “all’INPS, che penserebbe a ridistribuirli”. Ma sono sicuro che questa ventilata soluzione solleverebbe una enorme levata di scudi nel nostro paese.
Il rapporto va anche oltre. Tenendo, infatti, conto degli effetti che lo sviluppo e la diffusione della robotica e intelligenza artificiale potrebbe avere sull'occupazione e, di conseguenza, sulla congruità dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, esso raccomanda di tenere in considerazione l'eventuale necessità di introdurre obblighi di comunicazioni aziendali circa la quota del contributo della robotica ai risultati economici di una società; ciò allo scopo di evidenziare la giustezza della tassazione e dei contributi previdenziali pagati. E magari di limitare l’uso di robot.
In pratica, ciò che viene effettivamente detto è che le aziende che impiegano i robot dovrebbero essere tassate più di quelle che non li usano.
Ma è ovvio che questo è un nonsenso.
E’ un nonsenso perché l’Uomo usa le macchine perché le macchine rendono più efficiente il proprio lavoro. E storicamente l’Uomo ha sempre cercato di migliorare la propria efficienza lavorativa; usando cani pastore, cavalli, buoi per aratri, leve, carrucole, macchine, computer, robot, intelligenza artificiale. E’ giusto scoraggiare questa efficienza considerando che, nella realtà, più meccanizzazione adottiamo e più rendiamo sul lavoro ?
E poi come la mettiamo con gli altri continenti che non certificano i robot come “persona elettronica”? Se un robot europeo emigra negli USA (per esempio) per cercare lavoro; il suo datore di lavoro americano dovrà pagare maggiori contributi? Probabilmente no; e questo fatto potrebbe far emigrare una grande quantità di robot europei in altri continenti, perché il loro lavoro, lì, costerebbe di meno. Avremo quindi una fuga di “cervelli elettronici” dall’Europa. Viene però anche detto nel rapporto che altri continenti hanno allo studio il fenomeno robot. E ciò potrebbe portare a trattati di libera circolazione del lavoro robotico.
Sorge l’ovvio dubbio che una migliore efficienza, in Europa, si possa raggiungere rapidamente non togliendo i robot; ma togliendo alcuni umani. Ad esempio alcuni rappresentanti del Parlamento Europeo.
(*) Chi è interessato a leggere il documento UE lo trova a questo link:
Articolo pubblicato originalmente su “Agenda Digitale”